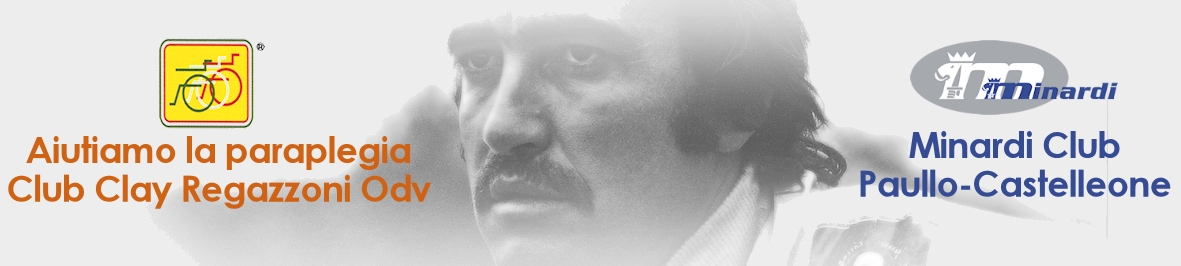Testata: Il Caffè.
L’incontro
La grinta è sempre quella. Perché non si diventa uno dei grandi della Formula 1 per sbaglio. Così come non si vince a Monza al volante di una Ferrari. Anzi, nessuno guida una “Rossa” se non ha dentro qualcosa di speciale. Una passione che a 67 anni, lo spinge ancora a partecipare a competizioni automobilistiche. Quasi che non avesse una “certa” età e non fosse obbligato a spostarsi su una sedia a rotelle. Ma Gian Claudio “Clay” Regazzoni con quel suo sorriso scanzonato e la parlata sciolta, sembra aver fermato il tempo. “Sono appena tornato dall’Equador – racconta Clay -. Ho partecipato alla “Carrera sudamericana Buenos Aires-Quito”. Ho anche diverse altre gare in programma. Soprattutto storiche”. Una passione, quella per i motori, che non è mai venuta meno. “Non posso e non voglio farci nulla – confida Clay -. Mi piace guidare. Mi è sempre piaciuto. È la mia vita”. Una vita di corsa. A gran velocità sui circuiti di tutto il mondo. Partendo da lontano. Da Lugano, dove nasce il 5 settembre 1939. Clay si avvicina abbastanza tardi al mondo delle macchine da corsa (era il 1963) ma, dopo i primi approcci in Formula 3, passa subito alla Formula 2 come pilota ufficiale della Tecno. Nel 1970 fa il suo esordio in Formula 1 al volante della Ferrari ottenendo una clamorosa vittoria nel Gran Premio d’Italia a Monza. La sua collaborazione con la “Rossa” prosegue anche nelle due stagioni successive, ma con scarsi i risultati. Nel 1973 “emigra” all’inglese Brm: una stagione da dimenticare. Lìanno migliore di Regazzoni è il 1974, quando tornato alla casa di Maranello a far coppia con una giovane promessa, Niki Lauda, sfiora il titolo di campione del mondo. Il 1976 è l’ultima stagione al volante della Ferrari. Poi passa alla Ensign ottenendo risultati di secondo piano. Esattamente come nel 1978 alla Shadow. Nel 1979 è con l’emergente Williams sponsorizzata da finanziatori arabi e la conduce anche alla prima, storica, vittoria nel Gran Premio d’Inghilterra a Silverstone. All’inizio del 1980 torna all’Ensign, ma un drammatico incidente nella gara di Long Beach porrà fine alla sua carriera in Formula 1 e lo costringerà su una sedia a rotelle. Però non si sfiora il titolo mondiale casualmente. Ed anche se dopo 132 Gran premi, 5 vittorie, 13 secondi posti, 10 terzi posti e moltissimi piazzamenti, ed aver realizzato per ben 13 volte il giro più veloce in gara, deve dare lìaddio alla Formula 1, pochi anni dopo torna a gareggiare, affrontando anche prove massacranti come la Parigi-Dakar, a bordo di vetture fuoristrada o addirittura camion. In questa girandola di corse e gare, non si è fatto mancare anche le competizioni con auto storiche. Nel 2000 poi, è giunta una grande soddisfazione: è stato votato, assieme all’ex-sciatrice Michela Figini, sportivo ticinese del secolo. Clay Regazzoni è anche autore di due bei libri: “È questione di cuore” (vincitore del Premio letterario del Comitato olimpico italiano e del Premio Bancarella), e “E la corsa continua”. Appunto: la corsa continua. Senza aggirare gli ostacoli. Soprattutto oggi. “Ci sono troppe persone che non ca piscono – sbotta Regazzoni -. Quando sono in viaggio, mi succede spesso di litigare con funzionari che, con la scusa delle misure di sicurezza, limitano i miei spostamenti. Io con queste persone ci litigo, ma tutti gli altri nella mia condizione troppo spesso non osano. E questo non è giusto”. Uno sfogo che non è fine a se stesso. “Nel 1994 – ricorda Clay – è stata costituita l’associazione che oggi si chiama: “Aiutiamo la paraplegia” – Club Clay Regazzoni. Lo scopo era ed è quello di legare lo sport alla beneficenza, così da raccogliere fondi da devolvere ad enti e istituti che si occupano dei problemi legati alla paraplegia”. In particolare l’associazione sostiene l’attività del reparto di Uroparaplegia dell’Ospedale di Magenta, riuscendo a raccogliere ogni anno oltre cinquantamila euro. “Ho trovato una ragione di vita supplementare nel mio impegno a favore dei paraplegici – confida Regazzoni -. Si fa davvero troppo poco per migliorare le condizioni di vita di chi vive su una sedia a rotelle”. Quella che non c’è più, invece, è la passione per la Formula 1. “È proprio così – ammette -, non seguo in sostanza più nulla. Mi annoio”. Ed il perché è presto detto: “C’è troppa elettronica e non ci sono più personaggi degni di tale nome”. Eppure tutti stravedono per Michael Schumacher. “È bravo – replica Regazzoni -, ma la sua classe non basta a dar lustro ad un ambiente che sembra sbiadito: la Formula 1 è solo un circo. Le gare sono state trasformate in semplici show per i media”. Inutile negarlo, sembra emergere un po’ di nostalgia per quei bolidi velocissimi, ma altrettanto instabili e non sempre controllabili. “Ho avuto la fortuna – ammette Regazzoni -, di gareggiare in un’epoca nella quale i piloti contavano almeno altrettanto delle loro auto. Oggi invece non è più così. Anche piloti di secondo piano possono emergere, grazie alla macchina e all’elettronica. Lo stesso Schumacher al volante di una monoposto di secondo piano finirebbe a metà classifica”. Sembra quasi che auto capaci di superare i 300 chilometri orari, siano facili da guidare. “Oggi in Formula 1 – dice Clay – fa quasi tutto l’elettronica e alla federazione internazionale dell’automobilismo va bene così. Alla Fia interessano solo i soldi. I gran premi, tre giri dopo il via diventano di una noia mortale. Non c’è spettacolo. Basti dire che i sorpassi oggi si fanno solo durante le fermate ai box”. Insomma, sembra essere tutto sbagliato. “Certo è proprio così – commenta amaro Regazzoni -. Fino a quando la Formula 1 sarà gestita da gente come Bernie Ecclestone, non cambierà assolutamente nulla: in pista non ci sarà più posto per il talento”. Insomma, nella sue parole sembra esserci anche poco ottimismo verso i nuovi giovani piloti impegnati in gara. “Questo però non significa che siano davvero bravi – replica -. Non si dimentichi che in pista è soprattutto la macchina a contare: determina il 90 per cento del risultato. E poi non si dimentichi che per giungere in Formula 1 serve molto denaro. Non è un caso se diversi giovani piloti hanno alle spalle, più che uno sponsor, una famiglia ricca”. (Alberto Cotti)